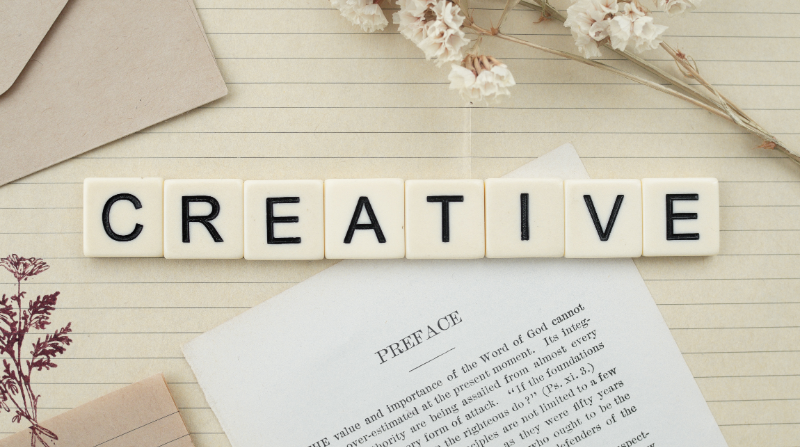Riflessioni sul processo creativo tra scrittura, ascolto e consapevolezza.
In un tempo in cui l’attenzione si restringe, iper stimolata dal sistema mediatico, l’atto creativo diventa una forma di resistenza e libertà. Sondando la natura del processo creativo, sfidando i miti del “genio solitario” e dell’ispirazione improvvisa, cerchiamo nella creatività uno spazio di autenticità e presenza.
Da dove vengono le idee?
Per Platone erano reminiscenze dell’anima; per i romantici, lampi di genio soffiati da una musa capricciosa; per i neuroscienziati, pattern neurali che emergono in stati di attenzione rilassata.
La verità, posto che ne esista qualcuna, sta in un intreccio e in un percorso che non procede lungo una linea retta ma si espande a spirale. Il processo creativo non è un fulmine a ciel sereno ma una preparazione fatta di slanci improvvisi e continue revisioni. In un’epoca che premia la produttività più della riflessione, riscoprire la natura del pensiero creativo e creare, può diventare un gesto radicale. Un ritorno all’essenziale. Un atto di libertà, non solo culturale, ma addirittura politico.
Nonostante l’apparente imprevedibilità delle idee, il processo creativo segue però spesso un ritmo riconoscibile, una sorta di architettura invisibile. Il modello proposto all’inizio del ‘900 dallo psicologo Graham Wallas – ancora oggi sorprendentemente attuale – suddivide il percorso in quattro fasi: preparazione, incubazione, insight o illuminazione e verifica.
- La preparazione è il terreno su cui tutto si fonda: studio, osservazione, raccolta di stimoli. È una fase attiva, ma spesso sottovalutata, in cui la mente si apre e si nutre.
- L’incubazione, invece, avviene quasi in sordina. L’inconscio lavora in profondità mentre l’attenzione conscia si sposta altrove: è la mente che elabora “dietro le quinte”.
- Poi può arrivare, improvvisa, un’illuminazione: un’intuizione, un collegamento, un frammento che accende un’idea.
- Infine, serve la verifica: vagliare, testare, limare, confrontare. È il momento in cui l’idea si relaziona con il reale.
Questo schema non è rigido né universalmente valido, ma offre una bussola utile per orientarsi nel mistero creativo. E, soprattutto, ci ricorda che la creatività non è solo ispirazione: è anche, e moltissimo, metodo, costanza e dedizione.
Sfatare il mito del genio solitario
Nella cultura occidentale, la creatività è stata a lungo avvolta da un’aura mitica. Dal fuoco rubato da Prometeo al lampo che folgora Archimede, l’idea geniale viene spesso narrata come una scintilla improvvisa, un dono raro riservato a pochi eletti. Questa visione, affascinante ma fuorviante, ha contribuito a costruire l’idea del “genio solitario”: un artista o inventore visionario che crea dal nulla, scollegato dalla realtà che lo circonda.
Ma la storia dell’arte, della scienza e della letteratura smentiscono puntualmente questo mito. Leonardo da Vinci trascorreva ore a studiare il volo degli uccelli prima di tracciare i suoi progetti; Beethoven annotava ossessivamente frammenti musicali prima di dar loro forma compiuta. La creatività, lungi dall’essere un atto isolato e improvviso, si nutre di tentativi, errori, contaminazioni. È una costruzione graduale, non solo un’epifania mistica. Sfidare questo mito significa riconoscere che la creatività non è un talento innato ma una qualità umana universale, una competenza coltivabile.
Non si attiva a comando, ma si prepara come un campo prima della semina: facendo pulizia e spazio, osservando, attendendo. E quando inizia a germogliare continuerà a farlo se le si dà attenzione.
Per farla emergere, serve imparare a sostare nell’intervallo. In quello spazio limbico dove non è ancora chiaro dove si sta andando, ma qualcosa si muove. Un’immagine, una parola che torna a farsi sentire, sono questi i primi segnali.
Creare è anche ripetere, ricominciare, lasciare andare e ridurre all'essenziale tutto ciò che invade l'opera senza conferirle valore. È accogliere il fatto che non tutto può essere chiaro fin da subito, e che l'opera nasce spesso da una forma che si svela negli anfratti, tra spostamenti e battute d'arresto. Il dio della creatività sa quanto essi siano preziosi e irrinunciabili per chi vuole creare. E spesso lo sforzo per resistere al fare è titanico.
Elogio dell’errore
Se il mito dell’illuminazione improvvisa ha deformato la percezione della creatività, ancora più dannosa è l’idea che l’errore sia il suo nemico. Al contrario: fallimenti, deviazioni, abbozzi incompiuti sono spesso parte integrante del processo creativo. Lo sono sempre stati.
Thomas Edison, a chi lo accusava di aver fallito mille volte nella creazione della lampadina, rispondeva:
“Non ho fallito. Ho solamente provato 10.000 metodi che non hanno funzionato.”
Thomas edison
In ambito creativo, l’errore non è una battuta d’arresto, ma una fase di esplorazione. Può aprire vie inaspettate, suggerire soluzioni alternative, mettere in discussione schemi rigidi. L’importante è cambiare prospettiva: non vedere l’errore come un inciampo, ma come una variazione sul tema. È nel confronto con il limite che si attivano le risorse più profonde del pensiero creativo.

Contaminarsi di idee
Una delle condizioni più fertili per la nascita di idee nuove è l’incontro tra ambiti diversi del sapere. La creatività vive di connessioni inattese, di cortocircuiti tra linguaggi, di contaminazioni tra discipline che, a prima vista, sembrerebbero lontane. L’inventiva, in questo senso, è spesso un atto di traduzione: trasportare un concetto da un campo all’altro, adattarlo, trasformarlo.
Il Rinascimento italiano, culla di menti poliedriche come quella di Leonardo da Vinci, è forse il miglior esempio nostrano di questa osmosi feconda tra arte, scienza, tecnica e filosofia. Ma anche la contemporaneità ne è piena: architetti che traggono ispirazione dalla biologia, musicisti che lavorano con codici informatici, designer che si confrontano con l’etica, cioè su come le loro creazioni possano influire in modo positivo o negativo sulla società e sull’ambiente.
È nell'intersezione tra mondi – e non nella loro chiusura – che fiorisce l'originalità.
Coltivare la curiosità trasversale è più che mai un atto creativo. Significa accettare l’ibridazione, farsi contaminare, uscire dai propri confini cognitivi. Perché spesso le idee più sorprendenti nascono proprio là dove le mappe finiscono.
Creatività nell’era digitale
Nel tempo dell’iper connessione e della velocità, il pensiero creativo può subire forti pressioni. L’automazione promette di generare immagini, testi e suoni su richiesta. Siamo immersi in un flusso costante di stimoli, chiamati ancor più a produrre, rispondere e condividere. La creatività, però, ha bisogno anche di vuoto, di tempo sospeso, di silenzio. L’ispirazione non ama l’urgenza. Essere creativi significa dunque anche difendere spazi di libertà interiore. L’atto creativo umano conserva un valore irriducibile: è espressione di coscienza e di desiderio. L’originalità non è solo novità: è risonanza tra l’interno e l’esterno, tra il sé e il mondo.
La pratica della scrittura
La scrittura è una delle forme di accesso alla creatività. Non serve “saper scrivere”, ma è fondamentale imparare ad ascoltare. La scrittura non è solo un prodotto, ma una pratica. Un modo per fermarsi, per elaborare, per riconoscere ciò che si muove dentro di noi.
Scrivere significa fare spazio. Rallentare. Annotare qualcosa che ci ha colpiti, anche se non sappiamo ancora perché. A volte basta un dettaglio – una voce captata per strada, una fotografia, una parola dimenticata che riaffiora dal passato, uno spiraglio tra le nubi che preannuncia il futuro. Agganci per tessere e ritessere il proprio filo. E più che cercare l’idea giusta, serve accorgersi che le idee arrivano quando smettiamo di forzarle.
Scrivere è anche un atto di fiducia: in sé, nel processo, nella possibilità che qualcosa di vero emerga se gli diamo ascolto.
L’ispirazione si manifesta spesso nei momenti di quiete, nella ripetizione di gesti quotidiani. Camminando, lavando i piatti, osservando alla finestra. Connessioni che si generano silenziosamente.
L’immaginazione ha però bisogno di nutrimento: immagini, letture, voci, esperienze sensoriali. E anche di respiro. La creatività vive nell’alternanza tra pieno e vuoto.
Non tutto può essere prodotto. Qualcosa deve poter solo esistere.
Un piccolo suggerimento pratico: scrivere ogni giorno un frammento, anche minimo, senza scopo. Un ricordo, una sensazione, un sogno. Tenere un taccuino a portata di mano. Non giudicare ciò che si scrive. Annotare. Lasciare traccia.

Intento e voce
Ogni gesto creativo nasce da un impulso. Ma più in profondità, nasce da un intento. Non un obiettivo da raggiungere, ma una qualità dell’essere che ci guida. È l’intento a dare forma al cammino, a sostenere il processo quando l’ispirazione manca, a ricordarci perché abbiamo cominciato.
Spesso ci si chiede: “Che cosa voglio scrivere?”. Una domanda più fertile potrebbe essere: “Che cosa scriverei se fossi… se volessi… portare qualcosa alla luce attraverso la mia voce narrativa?”. È da lì che può emergere un linguaggio autentico, che non imita, ma nasce dal vissuto.
Scrivere, creare, raccontare: non solo gesti espressivi, ma azioni che ci rimettono in contatto con ciò che conta, con ciò che pulsa sotto la superficie.
Creare non è solo fare. È prima di tutto imparare ad essere. È rispondere alla vita con un atto di presenza. È ricordare che dentro ciascuno di noi ci sono voci e mondi che meritano di essere conosciuti e, qualche volta, raccontati.
Essere creativi è un gesto rivoluzionario quando si impara anche a rifiutare l’idea della prestazione. Significa soprattutto: immaginare alternative. Forse è proprio questa, oggi, la funzione più alta della creatività: non inventare qualcosa di nuovo per stupire, ma aprire varchi in ciò che sembra già deciso.
Trieste ha per molti una voce creativa peculiare: la bora, che si insinua tra gli anfratti e si incunea in ogni angolo; di rado oggi impetuosa come la rappresentano cartoline storiche e scritti dei primi del ‘900. Resta comunque spesso udibile il suo sussurro tra i fori che crivellano le pietre aguzze del Carso. Linee di confine tra ambienti naturali e interiori, permeabili come il terreno calcareo in questi territori, che sanno trattenere e non dimenticano. Qui provo a vivere e navigare tra le onde della creatività, per me soggetto ma anche oggetto di indagine, forma di presenza e modalità per provare a restare al mondo.
Barbara Zippo è editor e consulente editoriale. Accompagna progetti editoriali e creativi indipendenti – narrativi, visivi e audiovisivi – dalla nascita dell’idea alla realizzazione finale, con particolare interesse per la bellezza come forma di resistenza attiva. Si occupa di libri, audiolibri, ebook, video racconti e progetti che uniscono parole, voce e immagini. Ha curato il docufilm per Progetto Mediterranea, spedizione nautica e culturale fondata dallo scrittore Simone Perotti e dalla dottoressa Francesca Romana Piro e conduce laboratori di espressione creativa con l’uso della scrittura, della voce e del corpo per adulti e ragazzi, creando spazi, soprattutto interiori, dove le storie possano germogliare, trasformarsi, trasformare e nutrire.
www.barbarazippo.net
entranellatuastoria@gmail.com

 Telegram
Telegram